![]()
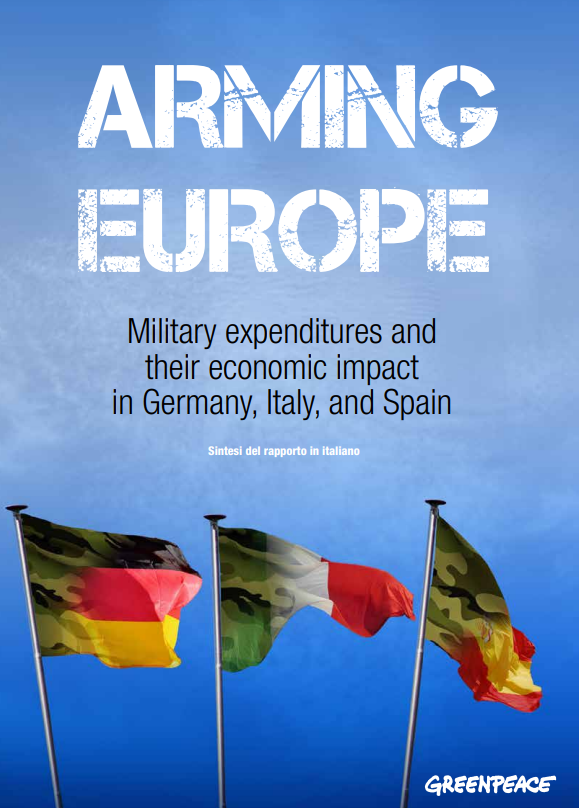
di Antonio De Lellis (Attac Italia)
Parlare di economia di pace oggi apre squarci drammatici perché significa considerare quella attuale come una economia di guerra.
Per avere un’idea del mondo in cui ci troviamo proviamo ad analizzare questi dati: nell’ultimo decennio, la spesa per le armi nei Paesi NATO della UE è cresciuta 14 volte più del loro PIL complessivo; in Italia la spesa per i nuovi sistemi d’arma è passata da 2,5 miliardi a 5,9 miliardi di euro.
Un passo verso la militarizzazione che rischia sia di destabilizzare ulteriormente l’ordine internazionale, sia di rallentare la crescita dell’economia e dell’occupazione in Europa e in Italia.
È quanto denuncia il rapporto Arming Europe, commissionato dagli uffici nazionali di Greenpeace Italia, Germania e Spagna, che rivela il minor effetto moltiplicatore delle spese militari rispetto a quello degli investimenti su ambiente, istruzione e sanità.
Nonostante le difficoltà delle finanze pubbliche italiane, la spesa militare è cresciuta con un ritmo senza precedenti anche nel nostro Paese, togliendo risorse alla spesa sociale e ambientale. Nel periodo 2013-2023, la spesa militare in Italia è aumentata del 30%. Quella per la sanità è aumentata solo dell’11%, la spesa per l’istruzione del 3% e la spesa per la protezione ambientale del 6%.
Questo studio dimostra che spendere nelle armi è un cattivo affare anche per l’economia.
Greenpeace ha stimato che 1.000 milioni di euro spesi per l’acquisto di armi generano un aumento della produzione interna di soli 741 milioni di euro, mentre la stessa cifra investita per istruzione, welfare e protezione ambientale avrebbe un effetto quasi doppio. Uno scarto ancora maggiore si registra nell’impatto occupazionale: i 3mila nuovi posti di lavoro creati dalla spesa per le armi salirebbero a quasi 14mila se la stessa cifra fosse investita nel settore dell’educazione, a 12mila se investita in sanità e a quasi 10mila nella protezione ambientale.
L’Institute for Economics & Peace (IEP) misura la pace in un mondo complesso. Dal Global Peace Index (GPI) 2023 risulta che l’impatto economico della violenza a livello globale nel 2022 è stato di 17,5 trilioni di dollari in termini di parità di potere d’acquisto. Questa cifra è equivalente al 12,9 per cento del PIL mondiale o a 2.200 dollari a persona, in aumento del 6,6 per cento rispetto all’anno precedente.
La necessità di una risposta sistemica per costruire la pace è urgente. I conflitti si stanno intensificando in diverse regioni, con le morti conseguenti che aumentano rapidamente. Il divario tra i paesi più e meno pacifici continua a far crescere il conflitto e, anche se molte misure di militarizzazione sono migliorate negli ultimi 15 anni, la proliferazione di tecnologie militari avanzate più economiche, la crescente concorrenza geopolitica e una sottostante corrente di instabilità politica in molti paesi testimoniano che un continuo deterioramento della pace globale sembra probabile.
Se il deterioramento della pace globale esiste, certo lo si deve al sistema economico attuale.
Secondo Stefano Lucarelli, le Corporation controllano sempre di più le altre società quotate. In cima a questa gerarchia si collocano poche imprese che controllano circa l’80% delle S.p.A.. A partire dal 2007/2008 gli indici di controllo indicano una concentrazione. Il pesce grande mangia il pesce piccolo. Ciò accade in USA, Cina e UE. Il meccanismo di concentrazione determina conflittualità. Il processo che passa tra il tentativo di integrazione commerciale, da una parte, e il protezionismo dall’altra, determina conflittualità con accumulo di spese militari. Resta al centro la tenuta delle democrazie europee.
La polarizzazione è tra coloro che hanno un surplus commerciale, con posizioni nette positive con l’estero, e coloro che hanno posizione di deficit di bilancia commerciale.
Fino a quando l’eccedenza di liquidità serviva per acquistare i titoli di Stato del debito estero dei paesi debitori, problemi non ci sono stati. Ma quando l’eccesso di liquidità è stato utilizzato per acquisti di pacchetti azionari e in primis in settori biotecnologici che dettano le traiettorie future, la situazione è cambiata radicalmente.
Le tendenze di cui parliamo precedono le ultime guerre, anche quella in Siria. I dazi, le tariffe e le sanzioni sono state applicate nei confronti dei paesi creditori che acquisivano pacchetti azionari di società dei paesi debitori. Queste modalità sanzionatorie mettono in moto meccanismi molto forti di distanziamento dal processo di integrazione. Ci troviamo dinanzi a una globalizzazione/protezionismo unilaterale che produce conflitti.
La guerra Ucraina è una risposta imperialistica dinanzi a questa guerra finanziaria, preceduta anche da sanzioni commerciali.
Mentre il conflitto israelo-palestinese è un conflitto quotidiano intensificato oggi dall’odio e dalla paura, ma non solo. Vi sono tanti fatti, spesso oscurati dai media, così come lo sono la natura e le origini di questa guerra. Questa non è semplicemente una lotta diretta tra due popoli sovrani. Si tratta, invece, dell’ultima guerra coloniale dell’età moderna, combattuta per stabilire l’egemonia e i diritti assoluti di un popolo sull’altro, come espressi nella legge “Stato nazionale del popolo ebraico” del 2018. Nonostante l’indiscutibile legame dell’ebraismo e del popolo ebraico con la Terra Santa, per i palestinesi questa è una lotta anticoloniale.
Israele è stato istituito come progetto coloniale di coloni europei – scelta che nessuno dei suoi primi leader politici ha negato – con l’indispensabile assistenza dell’imperialismo britannico. Nonostante la rete di miti creata per nascondere questi fatti, essi sono fondamentali per comprendere che i palestinesi avrebbero resistito a qualsiasi gruppo che avesse tentato di strappare loro la terra, qualunque fosse la loro religione o nazionalità. Il fatto che questo gruppo fosse composto da ebrei con un progetto nazionale, un profondo legame con la stessa terra e una storia di persecuzioni ed espropri altrove, culminata nell’Olocausto, ha dato a questa guerra la sua natura particolarmente disperata. E, come ha notato Edward Said, la sfortuna particolare dei palestinesi è quella di essere vittime di vittime.
Per più di mezzo secolo gli Stati Uniti hanno guardato con studiata indifferenza all’occupazione militare di questi territori e alla loro graduale annessione e assorbimento in Israele. Ciò contrasta palesemente con la risposta vigorosa degli USA all’occupazione russa di parte dell’Ucraina per un periodo molto più breve.
È difficile dare credito alle affermazioni degli Stati Uniti di sostenere l’autodeterminazione e la libertà dell’Ucraina, mentre hanno fornito decenni di sostegno essenziale a Israele per la sua occupazione dei territori arabi.
Come costruire una economia di pace? Prendo in prestito da Francesco Gesualdi alcuni stimoli e indicazioni generali che potrebbero essere ampliate e sviluppate.
Il primo passo da compiere è la messa al bando delle industrie di armamenti. Finché produrremo armi avremo guerre perché rappresentano l’occasione di consumo di materiale bellico.
La seconda grande scelta da compiere è l’abbandono del consumismo a favore della sobrietà. Il consumismo ha bisogno di quantità crescenti di risorse ed energia. Un’impostazione che spinge inevitabilmente alla sopraffazione per aggiudicarsi le risorse a buon mercato presenti nei territori altrui. Fino a ieri la lotta era per il carbone, il petrolio, i minerali ferrosi, oggi è per le terre agricole, i minerali rari, la biodiversità, l’acqua.
Il terzo passaggio è la capacità di orientarci totalmente verso le energie rinnovabili perché affidandoci al sole, al vento e alle altre forme di energia naturale, rompiamo la nostra dipendenza dalle risorse altrui.
Il quarto intervento è la capacità di potenziare l’economia pubblica, precisando che pubblico non è sinonimo di Stato, ma di comunità. Questo il senso della campagna Riprendiamoci il Comune e della Società della cura. Se riuscissimo a liberarci dai condizionamenti ideologici capiremmo che il rafforzamento dell’economia pubblica è non solo elemento di progresso umano e sociale, ma anche di pace, perché l’economia pubblica, a differenza dell’economia di mercato, non ha bisogno di espansione. Poiché non vende, bensì distribuisce, non ha la preoccupazione di procurarsi nuovi clienti. Il suo obiettivo è produrre quanto basta per soddisfare i bisogni dei propri cittadini, dopo di che è ben lieta di fermarsi. Non così per le imprese commerciali in lotta perenne fra loro per la conquista di nuovi mercati, se necessario con l’assistenza dei propri governi che magari non usano armi, ma ricatti e altri strumenti di pressione non meno insidiosi perché capaci di suscitare rancori dagli esiti imprevedibili.
E per finire la capacità di improntare i rapporti internazionali a spirito di cooperazione ed equità. Equità per garantire la giusta remunerazione ai produttori e cooperazione per sostenersi reciprocamente e colmare gli squilibri creati da cinque secoli di economia di rapina.
Tutto ciò, però, è possibile solo con un cambio di paradigma culturale.
In economia bisogna passare dai principi di guadagno, crescita, concorrenza, a quelli di equità, sostenibilità, cooperazione.
In ambito sociale bisogna passare dai princìpi di forza, vittoria, successo a quelli di mitezza, rispetto, sostegno.
Perché solo predisponendoci diversamente verso l’altro potremo passare da una cultura della guerra a una cultura della pace.

Foto 1: Rapporto Arming Europe Greenpeace
Foto 2: Roberto Ortiz (CC BY-NC-SA 2.0 DEED)
Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 52 di Febbraio-Marzo 2024: “Europa: a che punto è la notte?“






