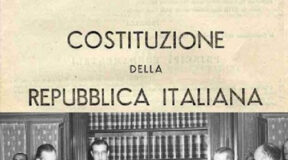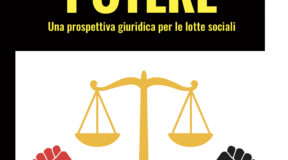![]()

di Franco Russo (politico)
Le guerre militari e commerciali che imperversano nel mondo sono il prodotto dell’estensione su scala globale del sistema economico capitalistico.
Questo sistema ha come sua forza vitale la competitività. Per conquistare posizioni di supremazia nei mercati, le imprese – siano esse produttrici di merci o servizi oppure istituzioni finanziarie – devono primeggiare nella concorrenza.
Da quando esiste questo modello di produzione, Stato e capitalisti si sono sostenuti a vicenda, inizialmente per affermare la potenza statale; in questo nostro tempo le politiche degli Stati sono direttamente guidate dagli interessi delle imprese, divenute transnazionali, per affermare il loro predominio nei mercati mondiali.
Così il capitalismo totale, esteso su scala planetaria e penetrato in tutti gli ambiti della società, ha portato al caos globale. Se può essere corretto parlare di fasi storiche, in quelle riguardanti l’espansione coloniale e/o imperialiste la ragion di Stato ha prevalso su quella economica mentre, nell’attuale fase, il rapporto si è rovesciato: l’economia domina la politica mentre la ‘ragione economica’ guida quella statale. Che questa non sia una tesi derivata da pregiudizi ideologici è dimostrato dai seguenti fatti.
Gli Usa con Donald Trump hanno dichiarato una guerra commerciale al resto del mondo per riequilibrare la loro bilancia commerciale, per accelerare il ‘ritorno in patria’ – il famoso reshoring – delle produzioni, che con la globalizzazione erano state decentrate, e per espandere financo il territorio nazionale inglobando il Canada e la Groenlandia.
Lo scopo è di riaffermare l’egemonia economica delle imprese Usa, al cui raggiungimento è di supporto la forza militare e politica, necessaria per contenere l’espansione, innanzitutto commerciale, della Cina.
Trump vuol porre fine alla guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina perché questa gli impedisce di concentrarsi nel confronto con il vero e unico avversario strategico degli Usa, la Cina, lasciando che l’Unione europea (Ue) provveda da sola ai suoi destini.
L’amministrazione Trump è consapevole che la geopolitica si è ormai fusa con la geoeconomia e che, dunque, solo se le sue imprese e le sue istituzioni finanziarie conquisteranno di nuovo la supremazia, ”con le buone o con le cattive”, allora il secolo americano potrà durare ancora.
La Cina da fabbrica del mondo, da vero e proprio sistema di subfornitura per i colossi industriali occidentali, è diventata un centro di produzione anche di merci e servizi ad alto contenuto tecnologico in grado di penetrare, grazie ai prezzi competitivi, negli stessi mercati dei paesi occidentali.
La Cina ormai primeggia nelle produzioni dei veicoli elettrici, dei sistemi informatici, delle attrezzature per le energie rinnovabili, oltre a detenere le più ampie riserve delle terre rare, necessarie per la duplice transizione verde e digitale. Xi Jinping vuole una Cina al centro della scena nel mondo, e fin dal 2013 aveva lanciato l’iniziativa Belt and Road per la costruzione di infrastrutture su scala mondiale con il proposito di creare un’area economica di dimensioni globali sotto il controllo cinese.
L’autocrate Vladimir Putin compensa la debolezza economica della Russia con la potenza militare ereditata dall’Urss, e, dati i persistenti livelli produttivi arretrati, conta sull’esportazione di materie prime ed energia per sostenere i suoi disegni espansionistici e ricostituire con le guerre (Georgia, Cecenia e Ucraina) un impero lungo i vecchi confini sovietici.
Il Davos Report 2023 aveva già evidenziato come la “guerra economica sia divenuta la norma, con crescenti scontri tra potenze globali” e prevedeva che la “intensa militarizzazione geoeconomica metterà in luce le fragilità poste dall’interdipendenza commerciale, finanziaria e tecnologica tra economie globalmente integrate, con il rischio di un ciclo ascendente di sfiducia e di disaccoppiamento”.
Il disaccoppiamento tra i sistemi economici, dovuto al reshoring, si è accentuato ed esteso fino a trasformarsi in guerre commerciali. Donald Trump usa i dazi per dare nuovo vigore alle imprese americane, incurante dei danni inflitti al sistema capitalistico nel suo insieme, con l’effetto di ottenere una divisione del mondo in grandi spazi, che alimenterà ulteriormente guerre militari e commerciali.
Ciò trova conferma nelle analisi di un recente working paper della Banca dei regolamenti internazionali – BIS Working Paper No 1249 – nel quale è messo in luce come le ragioni economiche stiano guidando le scelte di natura geopolitica, nel senso che le relazioni produttive e commerciali condizionano le relazioni tra Stati, creando alleanze e nuove interdipendenze tra quelli con interessi omogenei o perlomeno compatibili.
Si andrebbero così costituendo tre grandi spazi economico-commerciali: occidentale (Usa, Giappone, Australia, Canada, Ue); orientale (Cina, Russia, Iran e alcuni paesi dei Brics); e neutrale, con paesi quali India, Brasile, Turchia, Sudafrica.
Se la tesi della tendenziale divisione del mondo in grandi spazi è condivisibile, meno lo è la ripartizione dei paesi tra i tre blocchi, perché si sottovalutano gli effetti dirompenti su quello occidentale delle politiche di Trump, così come non vengono posti in luce i rapporti conflittuali tra i paesi Brics. Infatti, molti degli Stati definiti neutrali in realtà intrattengono rapporti commerciali e politici sia con la Cina sia con gli Usa e con l’Ue.
La guerra di Putin contro l’Ucraina e le politiche di Trump, volte a imporre dazi sulle merci di provenienza Ue e a disimpegnare le forze militari Usa nella difesa dell’Europa occidentale, hanno spinto l’Europa a cambiare radicalmente la sua postura geopolitica e geoeconomica: non è più ‘Venere’, per usare la metafora di Robert Kagan, ma va assumendo le sembianze di ‘Marte’, il dio della guerra.
Basta ascoltare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen quando recentemente, il 18 marzo 2025, ha detto: “Se l’Europa vuole evitare la guerra, l’Europa deve essere pronta alla guerra”. Ecco da dove viene il ReArm Europe Plan/Readiness 2030 plan, cioè il piano di riarmo che è stato presentato e discusso nelle riunioni (6 e 20 marzo 2025) del Consiglio europeo.
Il Piano prevede l’attivazione della clausola di salvaguardia in modo che gli Stati membri possano spendere in deficit fino all’1,5% del Pil, per rafforzare lo “strumento militare” e ricorrere ai prestiti dell’Ue, che raccoglierà risorse sui mercati finanziari per 150 miliardi di euro. Risorse che dovranno, però, essere utilizzate per il 65% per acquistare sistemi d’arma europei. Inoltre, la Banca europea per gli investimenti (Bei) potrà d’ora in poi investire nelle industrie belliche, possibilità che finora le era preclusa.
Con il Readiness 2030 si attua la nuova strategia delle classi dirigenti Ue, imperniata sulla sicurezza: non quella del benessere dei cittadini, bensì la sicurezza economica delle imprese, che necessita di quella militare.
Non a caso la sicurezza militare è al primo posto del Programma semestrale dell’attuale presidenza polacca. Programma in cui si prospetta un doppio obiettivo: il potenziamento della difesa ”basata sull’incremento delle spese militari” con ”una più forte industria militare colmando i gap nella capacità difensiva”; e il sostegno della competitività delle imprese per superare le dipendenze economiche soprattutto da paesi come la Cina, ritenuta competitor strategico (Programme of the Polish Presidency, pagine 4 e 5).
Mario Draghi, assurto ormai a vate dei destini dell’Ue, nel presentare il suo Rapporto sul futuro della competitività europea al Parlamento europeo a Strasburgo (17 settembre 2024), ha usato l’espressione ”una politica estera economica”, a intendere che le scelte di politica economica determinano quelle relative ai rapporti internazionali, o, detto altrimenti, che geopolitica e geoeconomia sono ormai una sola cosa. Si legga direttamente l’intervento di Draghi: affinché l’Europa rimanga libera « (…) noi dobbiamo essere più indipendenti. Noi dobbiamo avere più sicure catene di fornitura delle materie prime critiche e delle tecnologie. E noi dobbiamo espandere la nostra capacità industriale nella difesa e nello spazio».
Da ultimo, ha esposto posizioni analoghe nel suo intervento al Senato italiano (18 marzo 2025). Tra esse spicca quella sull’intreccio tra l’innalzamento della competitività delle imprese e il potenziamento degli strumenti militari a protezione del grande spazio economico Ue.
Devo, in conclusione, amaramente constatare che non sono attivi vasti movimenti che contrastino le scelte delle oligarchie al potere ma, se mai dovessero crearsi, allora si dovrebbero battere per dare efficacia e nuovo vigore al diritto e alle Carte internazionali e promuovere campagne contro le industrie belliche per la loro riconversione alle produzioni civili, a garanzia dei diritti sociali.
Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 54 di Aprile- Maggio 2025: “L’Europa che non c’è“