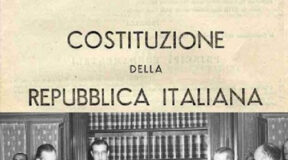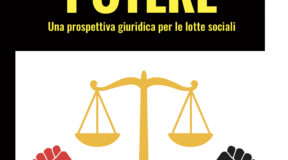![]()

di Fabrizio Eva (geografo politico)
Per cominciare ricordiamo che la Cina ha un’altra cultura rispetto alla nostra.
I cinesi, però, mostrano una grande capacità di inserimento nei meccanismi economici delle società occidentali dove emigrano, pur mantenendo la loro specificità e ricostruendo, come fanno del resto tutti i migranti (vedi Little Italy), il gruppo di affinità anche tramite la vicinanza fisica dei luoghi di lavoro e di residenza.
Nelle dinamiche geopolitiche i leader del partito guida cinese fanno ancora riferimento a un misto di principi che derivano da Confucio (stabilità e armonia garantite dalla gerarchia e dall’autorità), Laozi (dinamismo costante degli opposti, da cui la necessità di negoziare con l’Altro nel tempo, ma anche di modificare i contratti firmati) e Sun Tzu (dalla cui opera L’arte della guerra considerano una delle massime che è: “La miglior vittoria è quella che si ottiene senza combattere”).
Il lungo passato storico della Cina, ripreso come iconografia dopo il maoismo, che ha visto la Cina per secoli e secoli come l’area più ricca e organizzata socialmente del globo, porta alla definizione dell’obiettivo geopolitico del voler ritornare a essere i primi, il meglio, dopo la pausa temporanea prodotta dal pesante colonialismo occidentale.
La strategia utilizzata dal 1980 per raggiungere questo obiettivo è stata elaborata dopo aver analizzato i fattori che hanno portato gli Usa a essere la prima superpotenza e cioè: prima una dinamica economica interna grazie alla disponibilità di territorio e risorse e poi la costruzione di una potenza militare che si è espansa a tutto il globo, anche per una serie di eventi esterni quali la Prima e la Seconda guerra mondiale e il confronto pluridecennale con l’Urss.
L’evidente asimmetricità militare con gli Usa e il principio di Sun Tzu hanno portato la Cina post maoista a privilegiare la crescita economica sul modello capitalista, pur entro l’indirizzo politico del partito comunista, diventando la ’fabbrica del mondo‘ e cercando le risorse minerarie ed energetiche necessarie in Africa, America Latina e dovunque vi fossero. In questi continenti la strategia economica ha potuto avvalersi della narrazione iconografica basata sulla condivisione dello sfruttamento coloniale occidentale e sul reciproco interesse economico affermato come paritario. In realtà l’azione cinese non è stata e non è significativamente diversa dal neocolonialismo occidentale, ma ha aspetti di diversificazione che comunque mettono gli Stati africani e latino-americani in condizione di scegliere tra loro e noi.
Gli elementi di differenziazione sono soprattutto due: 1) la grande disponibilità di capitali da investire (grazie alla bilancia commerciale fortemente positiva a nostre spese) e la disponibilità a rinegoziare le clausole dei contratti; 2) l’assoluta non ingerenza nelle dinamiche politiche interne degli Stati partner (trattano con qualunque regime o soggetto politico in grado di garantire la fornitura di risorse).
Vogliono le materie prime, ma sono in grado di offrire la costruzione di infrastrutture grazie alle loro grandi imprese, spesso statali.
Sul piano globale la Cina punta al riconoscimento, per ora paritario, di essere una superpotenza con cui discutere le reciproche sfere di influenza. Per sfera di influenza si intende un gruppo di Stati che abbiano sempre un governo amico della superpotenza di riferimento; il sistema politico interno, inclusa la democrazia elettorale rappresentativa, deve portare sempre a questo risultato senza interferenze delle altre superpotenze o di qualche loro Stato vicino, in genere chiamato proxy.
L’accordo sulle reciproche sfere di influenza per la Cina si manifesta nella parola ’multilateralismo‘ in cui è sottinteso che gli Stati più forti e dominanti hanno un ruolo maggiore rispetto al generico e ipocrita multilateralismo del “tutti gli Stati sono uguali” che non rappresenta la realtà dei fatti.
I cinesi sono però anche molto pragmatici e così anche i leader del partito incluso Xi Jinping. Pretendono il rispetto formale e se non lo ottengono rispondono obbligatoriamente alle ’mancanze di buone maniere‘ di qualche leader straniero con la stessa intensità formale e allo stesso livello di ’rango‘ politico; ma trattano comunque su tutto e con chiunque, purché si rispetti la forma.

L’obiettivo, che per loro sembra ovvio e il più desiderabile, è il reciproco vantaggio, misurato, però, entro le complementarità economico-produttive del mondo attuale, che è disuguale nelle possibilità e asimmetrico nelle capacità di forza nelle trattative.
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, pur avendo una molteplicità di fattori e cause, ha evidenziato che la logica delle sfere di influenza è ancora sottesa alla narrazione geopolitica solo formalmente riferita all’Onu e alla cosiddetta ‘legalità internazionale’.
Dal 2008, dopo aver esplicitato chiaramente più volte che l’allargamento della Nato non poteva arrivare fino al confine della Russia (Paesi baltici sì, ma Bielorussia e Ucraina no), Vladimir Putin ha deciso di usare l’atto di forza sia perché è ed è stata una pratica continuamente usata dai più o meno ’potenti‘ durante e dopo la Guerra fredda, sia perché può contare su un fattore di superpotenza indiscutibile che è la deterrenza nucleare; l’unica in grado di pareggiare quella statunitense. Rivendicando concretamente il ruolo di superpotenza militare, non potendo competere sul piano dell’economia di consumo e finanziario, ma solo sul piano della disponibilità di materie prime ed energetiche.
Insomma, la storia non era affatto finita come negli Usa e alcuni in Europa pensavano dopo l’auto-dissolvimento dell’Urss.
L’invasione russa però ha messo la Cina in una parziale difficoltà geopolitica perché la costringe alla separazione evidente tra le affermazioni iconografiche del suo discourse, inteso come principio esplicito di posizione geopolitica e cioè il multilateralismo che si basa sulla integrità territoriale intoccabile degli Stati esistenti, e il pragmatismo operativo degli interessi economici oggettivamente complementari tra Russia, dotata di risorse materiali, e Cina con enormi necessità per la produzione di beni.
Pur aumentando le relazioni commerciali con la Russia in campo energetico e minerario, che devono andare di pari passo con la forma di dichiarazioni di amicizia, la Cina non può appoggiare l’invasione russa perché è in contrasto con la sua rivendicazione del principio di integrità territoriale per il ritorno di Taiwan in seno alla madrepatria. Nelle dinamiche geopolitiche la Cina mantiene, al momento, una posizione di apparente distacco, con generiche dichiarazioni a favore del multilateralismo e della negoziazione diplomatica, mostrando un carattere più assertivo solo per le questioni più geograficamente a lei vicine: Taiwan, il mar Cinese meridionale, la Belt and road initiative (Bri), o nuova Via della seta.
Nella sua seconda presidenza Donald Trump ha disvelato senza diplomazia qual è il pregiudizio anti europeo di una grossa parte della ormai minoranza bianca (appena sotto il 50% della popolazione), che non è cosa di oggi, ma origina già da alcuni leader fin dalla fondazione degli Usa a fine Settecento e ripresa a metà Ottocento dalla visione del Destino manifesto degli Usa di guidare l’intera umanità.
Trump ha esplicitamente richiamato il Destino manifesto nel suo discorso di insediamento. Ha definito gli Stati della Ue come parassiti che hanno rubato soldi agli Usa e che hanno fondato la Ue proprio con questo scopo. La nostra pluridecennale ’servitù’ volontaria‘ verso gli Usa e la Nato a scopo protettivo anti Urss e poi mantenuta nonostante il dissolvimento dell’arcinemico ora viene messa a dura prova da Putin e da Trump.
Chales Kupchan, politologo della Georgetown University di Washington e consigliere di Bill Clinton, già nel 2017 con la prima presidenza Trump e poi ancora adesso invita gli europei e la Ue a guardare con più attenzione e apertura verso la Cina perché gli Usa erano e sono in declino, e lo stesso ha fatto Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, a metà marzo.
Del resto, la Cina non può che trovare nell’Europa un continente che dal punto di vista storico, intellettuale e culturale possa essere all’altezza del loro millenario orgoglio storico-culturale. I punti di contatto e di reciproco dialogo ci sono, ma anche seri ostacoli che derivano più dallo sfilacciamento dell’ideale europeo che è andato crescendo dall’inizio degli anni 2000 e in particolare dopo l’allargamento massiccio del 2004.
I principi ideali sono quasi spariti nel dibattito pubblico e politico europeo per fare spazio a una politica di basso profilo centrata sui pur lodevoli e numerosi piani comunitari di sostegno e/o di indirizzo economico (sopra tutti il Pnrr) a compensazione degli squilibri economici generati dall’esterno (crisi finanziaria Usa del 2008, COVID-19) e dall’interno (opportunismo e auto centratura dei vari governi nazionalisti dell’Unione).
I tre punti fermi geopolitici iconografici dell’Unione europea (no guerra, cooperazione economica e negoziazione su tutto, disposti a spendere di più negli accordi) sono non conflittuali con le strategie cinesi e si può negoziare pragmaticamente con loro le possibili complementarità economiche.
Del resto, siamo andati a produrre in Cina senza problemi col presupponente atteggiamento neocoloniale dei nostri imprenditori privati che i cinesi sarebbero sempre rimasti indietro rispetto a noi.
La nostra concezione del multilateralismo è vicina all’attuale approccio cinese e a quel già citato principio di Sun Tzu e la Cina ha sommessamente (cioè tramite figure di secondo piano) dato come possibile la presenza di loro militari come peace keeper in Ucraina e a Gaza.
Problemi però ce ne sono.
Come Stati e come Ue siamo in competizione con la Cina in Africa per le risorse minerarie ed energetiche e abbiamo appoggiato il progetto della cosiddetta Via del cotone (India, Medio Oriente, Mediterraneo) in concorrenza con la Bri. Il corollario iconografico di questa competizione con la Cina, spinta fortemente dalla strategia Usa del contenimento della Cina nell’area dell’Indo-pacifico, è la nostra critica del (possibile) doppio uso dei porti commerciali cinesi e il nostro schieramento occidentale sulla questione di Taiwan e del mar Cinese meridionale, che al momento impedisce qualsiasi confronto concreto nel merito.
Il suprematismo Usa di Trump ha innescato una dinamica di riaggiustamento negli equilibri mondiali soprattutto nelle relazioni Usa-Russia e Usa-Ue.
La Cina rimane stabile nelle sue posizioni e nella sua forza economica nonostante i dazi di Trump, che già non hanno avuto molto successo durante il suo primo mandato. Anche la Ue e l’Europa nel suo complesso dovrebbero ripensare che ruolo globale avere, a mio giudizio recuperando i suoi principi etico-giuridici e facendone un ‘manifesto’ per poter sostenere un multilateralismo in cui siamo i migliori negoziatori possibili con la Cina, visto che siamo l’area culturale che può capire meglio e di più una cultura diversa, ma ricca e complessa come quella cinese.
Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 54 di Aprile- Maggio 2025: “L’Europa che non c’è“