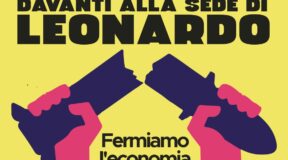![]()
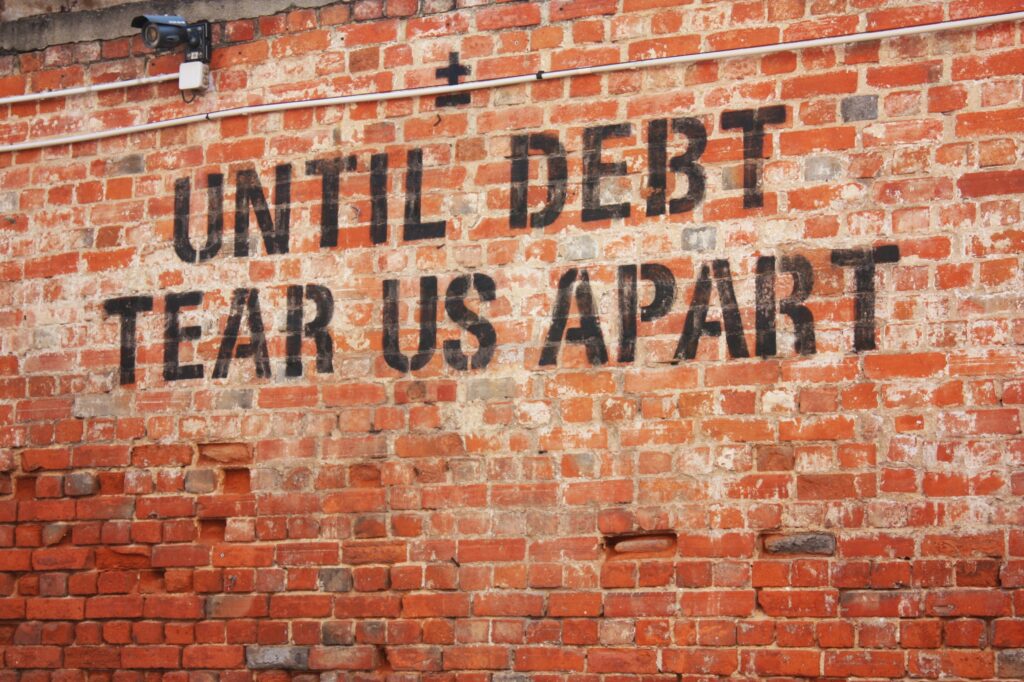
di Marco Bertorello, Danilo Corradi*
*articolo pubblicato su il manifesto del 22 marzo 2025 per la Rubrica Nuova finanza pubblica
L’economia occidentale cresce poco per ragioni strutturali e l’ondata sovranista sembra sempre più una risposta di ripiego che ambisce a scaricare le difficoltà verso altri, piuttosto che risolverle. La crescita dei debiti pubblici è stata in questi anni una rappresentazione plastica di questa difficoltà, in larga parte spiegabile come espressione di un supporto diretto o indiretto alla sfera finanziaria e produttiva. Nel mondo i debiti sovrani restano un problema centrale e crescente: nel 2025 nei paesi Ocse si arriverà all’85% del rapporto debito/Pil, 10 punti in più del 2019 e il doppio del 2007. Anche il costo del debito è in crescita: negli Stati Uniti va in interessi il 4.7% del Pil (era il 4.4% nel 2023), nei paesi Ocse il 3.3%.
Per alcuni analisti il debito pubblico statunitense sarebbe la principale ragione delle aggressive e inedite scelte di Trump. Gli Usa dagli anni Settanta hanno una bilancia commerciale in cronico disavanzo. Importano più di quanto esportano. Questo fa sì che per compensare il flusso di dollari che esce dal paese ci debbano essere flussi finanziari in entrata che sostengano la posizione debitoria degli Usa. Grazie a un incontestabile primato militare, tecnologico e finanziario il dollaro è la principale moneta di scambio internazionale. Ciò rende più facili politiche di espansione monetaria e più appetibile l’acquisto di titoli finanziari e di debito a stelle e strisce da paesi terzi, tra i quali diversi competitor, come la Cina. Questi squilibri si accumulano da tempo e sono espressione di un indebolimento del paese.
La nuova amministrazione prova a contenerli con politiche autocentrate: dazi, rilocazione industriale, riduzione della funzione di potenza egemone che risale al secondo dopoguerra. Ma non basta, non fosse altro perché gli effetti si possono misurare in tempi dilatati. Perciò tra gli obiettivi delle politiche di stop and go trumpiane fa capolino la proposta di una sorta di ristrutturazione del debito nazionale mediante formule di congelamento dei titoli di Stato per periodi lunghissimi (un secolo?).
Tale espediente darebbe un vantaggio immediato. Sarebbe rivolto, imposto o minacciato, ad alleati storici come l’Europa, ma anche a paesi emergenti che gravitano sotto la propria sfera d’influenza. Cioè rientrerebbe in quelle politiche di ricostruzione di alleanze basate sul divide et impera. Si potrebbe ipotizzare il debito come un terzo tavolo, dopo quello militare e commerciale, su cui ridefinire le geometrie mondiali. Alcuni paesi non vogliono essere vittime di dazi insopportabili? Oppure non vogliono essere abbandonati al proprio destino in termini di difesa militare? Allora, in cambio, devono accettare il congelamento degli interessi sui titoli di Stato di Washington o comunque condizioni favorevoli agli Usa sul piano del finanziamento del debito.
Un’operazione, quella della ristrutturazione del debito pubblico detenuto all’estero, non senza problemi. Se dovesse crearsi un clima di scontro sul debito sul modello dei dazi, chi acquisterebbe nuovi titoli di debito statunitensi? Se la domanda dovesse scendere salirebbero immediatamente i tassi aumentando il costo del debito. Storicamente si può ovviare a questa difficoltà imponendo il finanziamento dei deficit ad acquirenti interni, alla banca centrale o riducendo a zero (o quasi) il deficit pubblico. Sarà complesso per Trump perseguire simili scenari evitando turbolenze finanziarie.
La ristrutturazione così pensata, inoltre, non sarebbe certo guidata da pulsioni di giustizia sociale e redistribuzione della ricchezza, ma da un conflitto tra capitalismi che preserva banche e finanza proprie a discapito di quelle altrui. Servirebbero proposte alternative che prevedano una riduzione forzata dei costi del debito non in un singolo paese, ma attraverso una strategia redistributiva internazionale che rompa con quella centralità della finanza che caratterizza l’attuale capitalismo, magari per intravedere un nuovo modello.